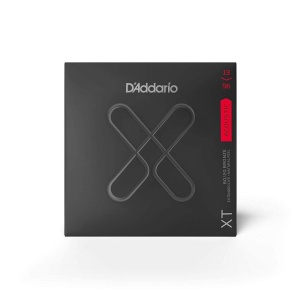Home » Magazine » Guitars & Bass » Il suono elettrico: storia e anatomia del pickup
Il suono elettrico: storia e anatomia del pickup
Che siano magnetici a bobina singola o doppia, passivi, attivi o piezoelettrici, i pickup rappresentano le fondamenta dell’amplificazione degli strumenti a corda.
Il funzionamento generale di questi dispositivi, a prescindere dalla tipologia specifica e dal campo di applicazione, è piuttosto semplice: convertono le vibrazioni in impulsi elettrici. Come questo avvenga dipende dalla tecnologia specifica sulla quale si fonda ciascun dispositivo. I pickup per chitarra sono fondamentalmente di due tipi: magnetico e piezoelettrico. Il primo, costituito da magneti contenuti negli avvolgimenti di un sottilissimo filo di rame, produce un campo magnetico che, alterato dalle vibrazioni delle corde in metallo, induce il segnale elettrico trasmesso all’amplificatore. Il pickup piezoelettrico, diversamente, deve la facoltà di produrre segnali elettrici ai cristalli di quarzo o ceramica che lo compongono. In questo caso il trasduttore, generalmente posizionato sotto il ponte, rileva le variazioni di pressione determinate dalla vibrazione di ciascuna corda, producendo esso stesso una tensione elettrica. Questo in estrema sintesi. Per una panoramica esaustiva sull’origine, le specifiche tecniche e il percorso di sviluppo dei pickup, è necessario fare un passo indietro, fino agli anni ‘20 del XX secolo.
Verso la metà del 1920 il chitarrista californiano George Beauchamp iniziò, con mezzi di fortuna e procedimenti sperimentali, a realizzare rudimentali dispositivi che fossero in grado di amplificare la sua chitarra. Ispirato dal funzionamento dei fonografi, costruì le prime bobine magnetizzandole con motori ricavati da lavatrici e macchine da cucire. Il primo vero pickup single coil vide la luce grazie all’intervento economico e ingegneristico di Adolph Rickenbacker, che nel 1931 fondò insieme a Beauchamp la Ro-Pat-In Company, destinata in seguito a diventare la Rickenbacker International Corporation. Il pickup, che si componeva di un avvolgimento di rame attorno ad una piastra metallica inserita fra due grossi magneti a forma di ferro di cavallo, venne installato per la prima volta sul prototipo della Hawaiian Electro Lap Steel Guitar, meglio conosciuta come Frying Pan (La padella) per via della particolare forma. A ridimensionare e rendere più moderno l’aspetto imponente del pickup di Beauchamp, posizionando i magneti sotto la bobina, penserà Gibson nel 1935 con il “bar pickup”, sulla scorta del quale venne successivamente prodotto il P-90, sempre a magnete singolo, ma con la piastra dotata di sei viti in acciaio regolabili in altezza, in modo che la variazione della loro posizione fra le corde e i magneti influenzasse la potenza del tono e del segnale. Lungo il percorso di sperimentazione e con l’intervento di altri produttori, primo fra i quali Leo Fender, alcuni modelli di single coil vennero dotati di più magneti generalmente caratterizzati da un unico avvolgimento in comune a tutti i poli. In altri esemplari il filo di rame può avvolgere ogni singolo magnete secondo lo schema di un collegamento in serie o in parallelo.
Il single coil a sei magneti viene comunemente riferito ai modelli Telecaster e Stratocaster prodotti da Fender a partire dagli anni ‘50 del secolo scorso e rappresenta lo standard per quanto riguarda i dispositivi a bobina singola. A prescindere dal numero di magneti e dal tipo di collegamento, il timbro prodotto da un pickup single coil è molto caratteristico e distintivo, brillante e definito. Tuttavia la tecnologia alla base dei criteri di progettazione produce una forte localizzazione del campo magnetico, rendendo il pickup sensibile alle interferenze elettriche esterne e di conseguenza molto rumoroso. Nel 1955 il dipendente della Gibson Guitar Corporation Seth Lover, progettò un pickup in grado di eliminare il ronzio e il rumore di fondo legati ai single coil. Al grido di “Buck the hum” (Resisti al ronzio), venne alla luce l’Humbucker PAF. Il pickup humbucker si compone di due bobine singole accoppiate e collegate in serie, con avvolgimenti e campi magnetici invertiti (RW/RP – Reverse Wound/Reverse Polarity), che determinano, in conseguenza dell’opposizione di fase, una soppressione del rumore di fondo. Inoltre, per via delle caratteristiche elettromagnetiche del dispositivo e per il fatto che le dimensioni raddoppiate catturano le vibrazioni di una porzione di corda più ampia, il suono prodotto è più caldo e ricco di armoniche, con una più rilevante predisposizione alla distorsione per via della maggior quantità di segnale. In base ai vari modelli e produttori, le bobine possono essere accoppiate orizzontalmente come nei modelli classici e nelle dimensioni ridotte del Duncan Hot Rail, oppure verticalmente come nell’humbucker stack che si presenta, una volta installato, con le dimensioni di un single coil.
I magneti utilizzati nella produzione dei pickup sono generalmente in AlNiCo o ceramici e determinano il suono dello strumento unitamente al tipo di architettura nella quale sono inseriti. AlNiCo è una lega composta da Alluminio, Nickel e Cobalto, in uso nella produzione dei magneti dalla fine degli anni ‘40, la cui capacità elettromagnetica è legata al tipo di mix utilizzato ed è classificata secondo una scala da 1 a 9. Per esempio gli hambucker PAF prodotti da Gibson utilizzano magneti in AlNiCo II, a differenza dell’ AlNiCo IV o V dei single coil di una Fender Stratocaster. Questa tipologia di pickup produce un suono pulito, morbido e caldo, con un carattere vintage riscontrabile con facilità tra i suoni dell’universo musicale contemporaneo. Chi invece ricercasse un suono più potente e moderno, con frequenze acute presenti e maggiormente incline alla distorsione, dovrà rivolgersi ai pickup ceramici.
Se nei pickup passivi fin qui descritti la corrente elettrica è generata dalla perturbazione del campo magnetico prodotto dalla bobina, nel caso dei pickup attivi le cose cambiano. Il numero ridotto di avvolgimenti attorno alla bobina, determina un circuito a bassa impedenza, con una minor produzione di corrente e conseguente limitazione di possibili disturbi dovuti a interferenze esterne. Il suono di base risulta pulito e silenzioso, ma con un volume molto basso per via della bobina sottodimensionata. La corrente necessaria a perfezionare il livello di uscita del segnale, è fornita da un preamplificatore alimentato a batteria, sotto la spinta del quale si produce un suono potente e pulito, con gain e sustain importanti, ma con possibilità di controllo della dinamica limitate rispetto a quelle offerte dai pickup passivi. Fender, Gibson, Seymour Duncan e Di Marzio sono tradizionalmente considerati i principali punti di riferimento nella produzione di pickup passivi, mentre EMG è il precursore dei circuiti attivi, ormai entrati a far parte dell’offerta commerciale di molti altri marchi. Negli strumenti acustici, la maggior sensibilità e l’esigenza di un sistema di preamplificazione che trasmetta il più fedelmente possibile il suono prodotto dalla relazione fra corde e legni e che sia libero da interferenze esterne, sposta l’attenzione sulle proprietà piezoelettriche di alcuni materiali.
La piezoelettricità è la proprietà comune ad alcuni materiali come quarzo, tormalina o topazio, di polarizzarsi e quindi produrre elettricità se soggetti ad una deformazione meccanica. Gli accendini, le puntine da grammofono e gli orologi contengono questi materiali per il loro funzionamento. I trasduttori per chitarra sono generalmente composti da cristalli di quarzo e vengono installati sotto la sella del ponte o a contatto con la cassa armonica. Sollecitati dalle vibrazioni delle corde, i cristalli producono una differenza di potenziale che trasferisce al preamplificatore le informazioni di altezza, timbro e intensità del segnale. Questo criterio di amplificazione si rivela molto comodo nelle esibizioni live, perché oltre a non risentire di interferenze esterne, ridimensiona notevolmente il fenomeno del feedback e restituisce un suono pulito e definito. Tuttavia la sola trasmissione della vibrazione delle corde non conferisce al suono tutta la dotazione di armoniche e sfumature che ne compongono la voce originale. Per quanto si cerchi di integrare questa mancanza intervenendo con equalizzatori e filtri di cui è dotato il preamplificatore, il pickup piezoelettrico non si inserisce efficacemente in ogni contesto. Per esempio per le registrazioni in studio è preferibile amplificare le chitarre con microfoni eventualmente accoppiati al segnale di linea separato.
Sia per i pickup magnetici che per quelli piezoelettrici, il requisito fondamentale risiede nella capacità di produrre corrente. Come un flusso di elettroni possa diventare suono e, in ultima istanza, musica, dipende da una convergenza di fattori e variabili incredibilmente ampia e imprevedibile.
Top of the Week
-
1.100,00 €
-
16,50 €
-
99,00 €
-
1.100,00 €
-
16,50 €
-
99,00 €